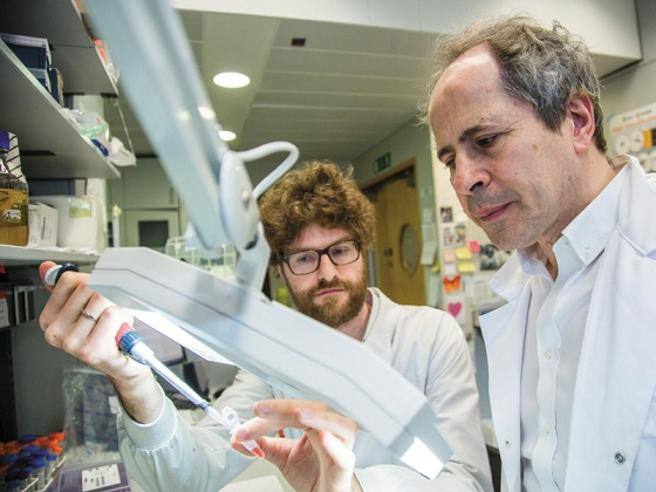Andrea Crisanti, direttore della cattedra dell’Unità diagnostica di microbiologia e virologia dell’università di Padova, è diventato famoso sin dai primi momenti dell’emergenza. Fu lui a realizzare lo screening totale sulla popolazione del comune di Vo’ Euganeo dopo il contagio del 21 febbraio, uno studio che ha fatto il giro del mondo, e che per primo evidenziò l’altissima percentuale di casi asintomatici (il 75% dei positivi). Il suo approccio all’emergenza lo ha reso una delle voci più autorevoli sull’argomento. Ha lasciato una lunga intervista a “Vanity Fair” , dove, appare chiaro che anche nella lotta contro il coronavirus, come contro ogni nemico sconosciuto, la strategia si sviluppa passo dopo passo. Studiarlo e scegliere le proprie mosse. La tempistica in questo caso è fondamentale per tornare il orima possibile alla «normalità».
Ma la vita tornerà ad essere come la conoscevamo o dobbiamo iniziare a dubitarne? «Torneremo alle nostre vite», dice Crisanti «Ma penso che questa emergenza cambierà tanti aspetti, a partire dalle nostre attitudini sociali. L’epidemia esaspererà sempre di più le differenze economiche e immagino che quando ne usciremo ci sarà anche un processo politico importante di rinnovamento. Saremo costretti a esaminare il modello di globalizzazione che abbiamo costruito: mi auguro che, senza cadere nell’idea di autarchia, forse capiremo che determinate produzione di valore strategico devono essere locali, penso alla farmaceutica, perché non credo sia una cosa buona che tutte le medicine generiche si producano in Cina o in India, o a altre produzioni per la sanità». Ma la domanda in questo momento è: quando ne usciremo?
Professor Crisanti, come vede il nostro prossimo futuro?
«Io vedo un processo molto lento fatto di “stop and go” su aree di regioni definite, altrimenti è facile far ripartire l’infezione. Credo che bisognerebbe fare un test su una regione italiana e quindi vedere che misure bisogna prendere per far sì che quella regione rimanga senza contagi. Le misure sono quelle elencate dal Ministro della Salute con il quale mi sento in totale accordo: dispositivi di protezione, diagnostica, dati, isolamento dei contatti e la possibilità di trasferire le persone malate in strutture idonee per non alimentare il contagio intra famigliare. Solo che tutte queste azioni richiedono una logistica e una preparazione non da poco».
Parla di processi lenti, ma è chiaro che diventa sempre più difficile questa situazione, sia dal punto di vita sociale, sia economico
«Lo so. Però per programmare la rimozione di queste misure sociali bisogna avere un progetto, che in questo momento non c’è. Poi applicarlo in una zona modello e vedere se funziona. Si può iniziare da una regione intera o anche solo da una zona, per esempio anche quella introno a Vo’ Euganeo sarebbe perfetta. In queste zone designate si può riaprire da subito per provare tutte le misure che poi bisognerà mettere in atto in larga scala, perché sulla carta si può progettare quello che si vuole ma poi si sa che nell’applicazione ci si scontra sempre con qualcosa che non si è pensato».
Perché il progetto sembra che tardi ad arrivare?
«Diciamo che un progetto ha dei tempi di gestazione…Guardi, io credo che il nemico più grande in Italia durante questa epidemia siano stati la burocrazia e gli interessi economici. Si doveva agire subito e tempestivamente: perché Bergamo non è stata dichiarata zona rossa in tempi celeri, mentre invece si pensava a rilanciare l’economia italiana?».
Cosa pensa dei test sierologici? Possono essere la soluzione per velocizzare questo processo?
«Che siano la soluzione è, come direbbero gli inglesi un “wishful thinking”, vorremmo che fosse così, ma no, non è questo il caso. In realtà si sta ancora valutando l’idoneità di quest test, di cui ne esistono a decine, anzi il comitato tecnico del ministero per ora ha espresso perplessità sulla loro utilità. Sembrerebbe che non vedano le IgM, utili per la diagnosi perché sono il primo segno che il sistema immunitario è entrato in contatto con il virus, mentre pare vedano le IgC, che l’unica cosa certa dicono è se hai contratto la malattia da qualche tempo. Che una persona risulti immune se ha contratto la malattia, non mi sento di dirlo, anche perché gli anticorpi non rimangono costanti, non sappiamo se sono protettivi e quanto. In generale è molto difficile sviluppare protezione contro i coronavirus, che per esempio sono la causa del comune raffreddore. Non è che su uno prende il raffreddore poi è protetto negli anni successivi».
Ci saranno nuovi focolai appena usciremo, e se sì cosa dovremo fare in caso?
«Sì ci saranno. La vera domanda è: avremo imparato la lezione e sapremo isolarli rapidamente? Ci saremo attrezzati per isolarli? Come dicevo è un problema di logistica e di preparazione. Non si può riaprire e basta, bisogna mettere in atto una complessa rete di attività. Per esempio, cosa facciamo? Riapriamo senza sufficienti mascherine per il personale medico e per le persone? O senza avere aumentato la nostra capacità di fare diagnosi? Bisogna fare scorte di milioni di mascherine, avere la capacità di fare migliaia e migliaia di tamponi, insomma bisogna prepararsi».
Fino a quando dobbiamo aspettarci di convivere con il virus? Per la parola “fine” dobbiamo aspettare il vaccino?
«La parola “fine” forse la metteranno le terapie più che il vaccino. Sono più fiducioso nei confronti di una cura, perché il vaccino per la natura stessa del virus non so se sarà definitivo, i coronavirus non inducono immunità protettiva. Al momento esistono indicazioni che non lasciano ben sperare, anche se preferirei essere smentito».
Il caldo potrebbe aiutarci?
«Spero di sì, ma è presto per dirlo».
Quando una persona anziana, o una persona con altre malattie o immunodepressa potrà riprendere un vita normale?
«Difficile da dire. Fino a che c’è il virus e non c’è una terapia o un vaccino non vedo soluzioni».
Lei suggerisce di usare le mascherine anche in casa con la propria famiglia, che funzione hanno?
«Questa è un’osservazione che viene dallo studio di Vo’ Euganeo. Abbiamo calcolato che la probabilità di infettarsi se si condivide la stessa abitazione è 100 volte superiore rispetto a quella che corre chi non si trova nella stessa situazione. Quindi in famiglia bisogna proteggersi molto bene nel caso uno dei membri si infetti e porti la malattia nel nucleo famigliare, con sintomi o in modo asintomatico».
Le mascherine per uscire sono obbligatorie in alcune regioni. Cambierà qualcosa?
«Io penso che sia una buona misura di precauzione, anche se non credo che siano molti i contagi che avvengono tra le persone che si incontrano casualmente, credo che la maggior parte dei contagi avvengano in una situazione intra famigliare o dalle filiere che sono rimaste aperte. Per intenderci, non credo che ci si ammali in coda al supermercato anche se avere la mascherina è comunque meglio».